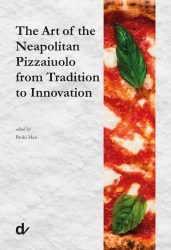È importante partire da un presupposto: la Terra è un pianeta fragile e fra i Paesi che la compongono l’Italia a causa anche della sua giovanissima età è tra i più fragili.
Mi riferisco a Terremoti, eruzioni vulcaniche, uragani, alluvioni, frane e via elencando, fenomeni naturali che diventano catastrofi o calamità come variamente si definiscono soprattutto in presenza di esseri umani e dei loro prodotti materiali. Poiché questa, molto spesso inevitabile, presenza in assenza di opere ed azioni di prevenzione provoca vittime umane e danni materiali, la domanda è “che fare?”.
La risposta che mi sento di dare è che oggi la situazione è tale che non dobbiamo più pensare solo al prima e al dopo un evento catastrofico, ma anche al durante il suo prevedibile verificarsi.
Voglio dire che il prima, cioè la previsione e la prevenzione dei danni sono di fondamentale importanza; così come è importantissimo che una volta subìto il danno si intervenga con la ricostruzione delle cose e delle persone, cioè con la resilienza. Ma questi due fondamentali obiettivi non possono ignorare che oggi, e da qualche tempo, bisogna fare i conti con gli eventi provocati dai mutamenti climatici che non hanno la durata di una scossa o di un’eruzione o di un’alluvione o di una frana. Ma durano molto più a lungo nel tempo: tanto da costringere a modificare i nostri comportamenti. Di conseguenza bisogna prendere in seria considerazione la necessità di adattarsi durante questa durata che può essere anche irreversibile.
Una cosa resta ferma ed è che quale che sia l’evento potenzialmente calamitoso nei confronti del quale vogliamo difenderci e al verificarsi del quale vogliamo adattarci, dobbiamo aver coscienza di due atteggiamenti che ci competono: l’impossibilità di interferire con la probabilità che l’evento si manifesti; la possibilità (che è anche un dovere) di intervenire sulla vulnerabilità dell’area, del territorio, su cui si può abbattere.
Oggi, insomma, un fenomeno naturale potenzialmente calamitoso come, ad esempio, un terremoto o un’eruzione vulcanica, non deve essere visto solo come una sciagura da subire o dalla quale fuggire. Perché è sempre più diffusa la consapevolezza di poter convivere con molti fenomeni naturali riducendone la pericolosità.
Insomma il problema non è solo come prevenire e difendersi, ma è anche “dopo e durante il disastro che fare?”.
Le risposte sono due e rientrano nei concetti (e nelle pratiche) della resilienza e dell’adattamento concetti e pratiche che hanno a che fare con la fisica e la biologia ma che sono perfettamente applicabili al genere umano.
La resilienza
La resilienza è la capacità di un materiale di resistere a urti improvvisi senza spezzarsi e di riprendere la sua forma originaria. Naturalmente non tutti i materiali hanno questa possibilità e non tutti allo stesso modo.
Ma se il “materiale” è quello umano e, quindi, dal campo della fisica si entra in quello delle scienze sociali, che cosa succede agli esseri umani dopo uno shock traumatizzante? Dopo un disastro naturale, dopo un attentato terroristico con il loro carico di morti e danni materiali? Le reazioni sono diverse; la ricostituzione dello stato originario (la resilienza) avviene in modi e tempi diversi e consiste nella capacità umana di affrontare le avversità della vita, superarle e uscirne trasformati o addirittura rafforzati.
Bisogna anche riconoscere che diversa è la reazione se lo shock colpisce soggetti “preparati”. Soggetti, cioè, che, per averne già vissuto l’esperienza, ne hanno la percezione, “sanno di che si tratta”. La percezione del rischio, basata su esperienze vissute, è una discriminante importante nel determinare tempi e modi della resilienza.
Ma, al contrario del materiale “fisico”, quello umano può non farcela da solo a riprendersi. Ha bisogno di un aiuto. Dopo un terremoto non si ricostruiscono solo le case: più impegnativo talora è ricostruire le menti, le coscienze turbate, talora sconvolte dall’evento.
L’eccezionale numero di vittime in eventi come l’attentato alle torri gemelle e tutti quelli che negli ultimi anni hanno colpito Francia, Belgio, Gran Bretagna fino all’ultimo nella moschea di Al Rawdah nel Sinai Settentrionale; i terremoti in Belice, Friuli, Irpinia, nel centro Italia; l’uragano Katrina, gli tsunami nelle Filippine e in Giappone; questo numero, per quanto elevatissimo, sottostima la realtà perché non tiene conto delle “vittime superstiti”, dei sopravvissuti agli eventi disastrosi.
Non tiene conto, cioè di quanti per anni avranno negli occhi e nella mente l’aereo che trapassa le torri, la scossa che scuote le abitazioni e quanto c’è dentro, il vento che solleva auto e case, il mare che travolge tutto quanto trova lungo la sua strada.
L’obiettivo per chi si propone questo “aiuto” è di non far perdere la memoria delle vittime, ed essere un punto di riferimento per i sopravvissuti e uno stimolo per le istituzioni.
Come si vede, l’approccio e l’approfondimento del discorso sulla resilienza sono di ordine squisitamente socio-psicologico e riguardano il comportamento degli esseri umani come risposta ad una sofferenza scatenata da un evento doloroso.
Né è solo l’essere umano a trovarsi di fronte a questo problema in seguito ad un evento traumatizzante. Lo sono anche l’economia, la società nel suo complesso o una più piccola comunità; lo è la politica internazionale o locale. Possono esserlo anche, e lo sono specialmente a valle di un evento calamitoso, l’ambiente e il territorio.
I milioni di persone che hanno evacuato le aree minacciate dall’uragano Irma sapevano bene che esse quasi ogni anno e verosimilmente sempre più di frequente in futuro, vivono in zone di estrema vulnerabilità e di enorme esposizione a questo rischio. Non per questo hanno desertificato quei territori. Si sono adattati a questa situazione; hanno costruito barricate a difesa dei loro beni immobili con la speranza che ritornandovi potessero trovarne il meno distrutto possibile. E questo è un esempio che riguarda “solo” alcuni milioni dei 7,5 miliardi di abitanti della Terra. Altri se ne potrebbero fare per altri casi con numeri comunque “piccoli”. Ma c’è una situazione che può coinvolgere la Terra nella sua interezza e la totalità dei suoi abitanti che, nel frattempo potrebbero essere diventati 10 miliardi. È il fenomeno dei mutamenti climatici alle cui conseguenze o ci si adatta o si corre il rischio della paventata sesta estinzione.
Adattarsi, dunque. Che non è assuefazione o rassegnazione.
L’adattamento
L’adattamento in biologia si riferisce alla facoltà degli organismi viventi di mutare i propri processi metabolici, fisiologici e comportamentali, consentendo loro di adattarsi alle condizioni dell'ambiente nel quale vivono.
La storia della vita sulla Terra è proprio la storia dell’adattamento all’ambiente. Attraverso una serie di mutazioni e di selezioni, le specie vegetali e animali si sono continuamente adattate all’ambiente in trasformazione, trovando ogni volta le soluzioni giuste per sopravvivere nei climi più diversi. Poi è intervenuta la specie umana che ha ritenuto di modificare questa tendenza cercando di adattare l’ambiente alle sue esigenze come sta facendo da almeno dodicimila anni rischiando l’estinzione. A meno che non riesca ad adattarsi alle mutate situazioni che ha provocato forzando la natura che non ne vuole sapere.
Quello dei mutamenti climatici sempre più evidentemente provocati da comportanti umani – checché ne dicano i “negazionisti” – è l’esempio più calzante. Il mutamento climatico non è solo causa del temuto aumento delle temperature con tutto quello che ne consegue dallo scioglimento dei ghiacciai nelle calotte polari all’innalzamento del livello degli oceani, ma è anche l’incremento per numero e intensità di quelli che vengono definiti eventi estremi.
Già da anni se ne registra la presenza su tutta la Terra, per cui 195 Paesi a dicembre del 2015 hanno firmato a Parigi un accordo col quale si propongono di bloccare l’aumento delle temperature medie del pianeta a 2 gradi centigradi, meglio ancora se ad 1,5.
Non entro nel merito dei contenuti di questo accordo, calcolo solo che da oggi 2017 al 2100 passano 83 anni. Che cosa succederà in questo lungo periodo? E dopo?
Certamente non c’è da immaginare un automatismo tra la riduzione della emissione di gas serra in atmosfera e il blocco degli eventi provocati dal mutamento del clima già in atto da tempo. Né è immaginabile che una volta raggiunto l’obiettivo tutto tornerà ad essere com’era cinquant’anni fa.
Si sarà evitato che tutto peggiori; si saranno ottenuti cieli più limpidi e si sarà salvato qualche arcipelago dalla sommersione… ma non si potrà certo intervenire sull’irreversibile accumulo di CO2 in atmosfera.
Insomma ci avviamo a vivere su un pianeta diverso e questa diversità richiede un adattamento per vivere nel migliore dei modi possibile, nel migliore dei mondi possibile.
L’informazione
La speranza per il futuro dovrebbe essere che si abbia sempre meno bisogno di resilienza, nel senso classico del concetto, perché il prima e il durante di cui dicevo consentano di rendere più sicuro e vivibile il dopo. Il che significa, almeno: mettere in sicurezza il territorio per garantire la convivenza col rischio sismico ed evitare il rischio frane; alleggerire il carico demografico nelle aree vulcaniche e la loro conseguente maggiore vulnerabilità; adottare tutte le possibili misure di prevenzione degli incendi che devastano ogni anno centinaia di migliaia di ettari in più aree della Terra e presidiarle nei periodi di massima esposizione al rischio … eccetera. Un “eccetera” che riguarda tutto il ricco serbatoio delle opere di prevenzione dei danni legati al verificarsi di eventi naturali.
Ma tutto questo può realizzarsi tanto più e tanto meglio in una società – che deve sempre più coinvolgere l’intero pianeta – adeguatamente e correttamente informata. Obiettivo che tarda ancora e pericolosamente a realizzarsi: anche nei Paesi economicamente e socialmente più sviluppati.
È, questa, un’osservazione che mi suggerisce la dolorosa notizia del suicidio, in Francia a metà novembre, di Guillaume Valette, uno dei superstiti della strage al Bataclan di Parigi del 13 novembre 2015. Un doloroso evento che invita a riflettere sul troppo trascurato concetto e sulla troppo trascurata pratica della resilienza.
L'associazione Fraternité et Vérité riferisce che il giovane Guillaume Vallette (31 anni) aveva rifiutato di farsi assistere dalla famiglia, né da un'associazione per il sostegno alle vittime. Perciò questa associazione, molto opportunamente, sostiene che "Il trauma psicologico subìto con questi attentati è profondo e duraturo, e va considerato e curato", e che, di conseguenza, si ha il dovere di ricordare l’importanza di farsi assistere, dalla famiglia, da un'associazione, un medico, uno psichiatra, uno psicologo. Un’importanza che non si può comprendere da un momento all’altro dopo avere subìto il danno, ma solo in una società informata preventivamente sulle caratteristiche del danno e sulla necessità di essere assistiti per recuperare il “piacere” alla vita.
Continua ad essere vero, secondo me, che l’auspicio dovrebbe essere quello di aver sempre meno bisogno di resilienza, ma la necessità di disporne come strumento di aiuto e sostegno alle “vittime superstiti” resta sempre indispensabile.