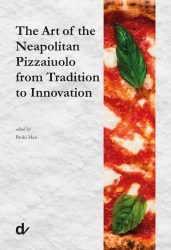Reduce da una lunga fase recessiva, l’economia italiana ha iniziato nell’ultimo biennio a registrare una timida ripresa, alimentando più di una speranza sull’uscita del Paese dal tunnel della crisi. I dati Istat sulla crescita tendenziale del Pil (agosto-settembre 2017) ci informano in effetti che il recupero della nostra economia va a consolidarsi, superando perfino le previsioni contenute nel DEF 2017 del Governo. E se ciò non bastasse, segnali ancora più ottimistici sono quelli che provengono dalle puntuali elaborazioni della Svimez[1], che mostrano come anche la deriva del Mezzogiorno sembra essersi arrestata. Il Mezzogiorno, infatti, cresce ad un tasso superiore a quello del resto del Paese (1% contro lo 0,8% del Centro-Nord) confermando nel 2016 una ripresa che si era già manifestata nell’anno precedente e che era stata per molti versi giudicata “eccezionale”. Ma la questione è assai più complessa, ed è proprio guardando in maniera più circostanziata alle recenti dinamiche di “svolta” delle variazioni del Pil, tanto a livello nazionale quanto nel confronto tra Centro-Nord e Sud, che si comprende che la rinascita di una fase di sviluppo per il nostro Paese è ancora molto di là da venire; mentre è nelle pieghe di un “nuovo dualismo” tra Mezzogiorno e Centro-Nord che si vanno rafforzando i fattori che preludono a una sostanziale marginalità dell’Italia rispetto al resto d’Europa.
Non è da oggi che i dati ci dicono che la crescita del Pil italiano è inferiore alla media europea[2] e che l’origine della divergenza va ricercata molto indietro nel tempo, risalendo almeno alla seconda metà degli anni Ottanta[3]. Tuttavia, complice anche la vastità e la durata della crisi internazionale, l’attenzione dedicata allo specifico “ritardo” dell’Italia, scarsa di per sé già da prima, si è completamente dissolta, spostando ogni tipo di analisi e riflessione sul terreno della depressione globale e, in seconda battuta, su quella europea. Il recente il miglioramento del quadro internazionale sembra però aver fatto emergere una nuova consapevolezza, poiché i progressi compiuti dall’Italia, benché apprezzabili, non sono affatto in linea con quelli raggiunti dai maggiori partner europei. Ed è così che, seppure a fatica, sta prendendo sempre più piede l’idea che il Paese è appena uscito dalla fase più buia della crisi, ma che lo scarto rispetto alla crescita delle altre economie europee è ancora significativo e richiederà ancora molti sforzi per poter essere almeno parzialmente colmato. Lo ha precisato anche il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco[4], sostenendo che la ripresa in atto è congiunturale e non strutturale, e che le nuove positive previsioni al rialzo registrate dal Fondo Monetario Internazionale per il Pil italiano (1,5% sul 2017, a fronte comunque di un +2,3% della media UE) indicano semplicemente uno scostamento temporaneo al di sopra del tasso di crescita “di lungo periodo”.
Il confronto tra le più recenti cifre sull’occupazione e il tasso di crescita del Pil – sottolinea Francesco Saraceno dell’OFCE di Parigi[5] - è d’altra parte più che eloquente nel delineare il quadro di debolezza entro il quale sta prendendo forma la ripresa dell’Italia. Se infatti l’aumento dell’occupazione - reso noto dall’Istat all’inizio di settembre 2017 - riporta il Paese ai livelli del 2008 (23 milioni di occupati), il Pil registrato a fine del 2016 è ancora inferiore del 7% ai livelli pre-crisi. Siamo perciò di fronte a un’economia che non solo è meno ricca di prima, ma che produce anche una minor ricchezza per ogni lavoratore impiegato. In quasi dieci anni di crisi “il numero di ore lavorate per dipendente (nelle imprese con più di 10 lavoratori) è diminuito circa del 6%” e “la quota di part-time (nelle imprese più grandi, per cui l’Istat fornisce i dati) è aumentata dal 14% al 20,8% …un aumento del part time che sembra ultimamente accompagnarsi a un rallentamento dei contratti a tempo indeterminato. …Nel periodo tra luglio 2016 e luglio 2017 , dei 378 mila nuovi lavoratori dipendenti 286 mila sono a termine e solo 92 mila a tempo indeterminato”[6]. Ancora più cruciale è poi il forte cambiamento nella composizione settoriale dell’occupazione, che “continua a stagnare nei settori a più alto valore aggiunto, spesso esportatori, dove la ripresa dell’attività (che resta moderata) avviene grazie ad aumenti di produttività (e salari). L’occupazione cresce, quindi. Ma con essa le disuguaglianze salariali e la trasformazione della nostra economia in servizi a bassa produttività e non suscettibili di trainare la crescita del Paese nel medio periodo”[7]. Il Rapporto Istat 2017 sulla competitività dei settori produttivi[8] ci informa inoltre che “la quota dell’Italia sul valore delle esportazioni mondiali è diminuita dal 4 per cento del 2001 al 3,4 per cento nel 2008, attestandosi al 2,8 per cento nel 2015” sottolineando come contestualmente l’Italia sia passata dall’essere sesto a decimo paese esportatore e come la caduta dell’export italiano nel 2008-2009 sia “stata la più ampia dell’UE28 e il successivo recupero meno rapido” con difficoltà “particolarmente evidenti per le produzioni tradizionali del Made in Italy, nelle filiere del mangiare-vestire abitare, in un periodo caratterizzato da una crescita della domanda estera per questi prodotti superiore a quella media delle importazioni mondiali”; mentre, più in generale, le imprese manifatturiere italiane che svolgono attività di export dipendono ancora fortemente dalla domanda interna.
Che la domanda interna possa trarre nuova linfa dallo slancio dell’economia meridionale dell’ultimo biennio è, peraltro, cosa alquanto dubbia. Anche nell’ipotesi che il Mezzogiorno continui a crescere ai ritmi attuali – ci ricorda infatti Svimez[9]- i livelli del Pil pre- crisi sarebbero recuperati solo nel 2028, con un ritardo di dieci anni rispetto alla previsione formulata dalla Banca d’Italia sul ritorno dell’intera economia italiana ai livelli del 2007. A conti fatti si verrebbe ad avere un “ventennio di “crescita zero”, che farebbe seguito alla stagnazione dei primi anni Duemila, con conseguenze nefaste sul piano economico, sociale e demografico”. Né sembrano esservi le premesse perché il miglioramento del Mezzogiorno possa rafforzarsi. Parte della ripresa del Sud deve infatti confrontarsi con la profondità della riduzione della produzione manifatturiera che l’ha preceduta, pari a -29,8% tra l’inizio della crisi e il 2016, contro il 9,5% del resto del Paese. Allo stesso tempo il miglioramento nella crescita della produzione, dell’occupazione e perfino del reddito disponibile (+1,3% nel 2016 contro l’1% del Centro-Nord) non si sono riflessi in un adeguato aumento dei consumi delle famiglie (inferiore, questa volta, a quello del Centro-Nord), mentre è mancata la capacità degli investimenti di fungere da volano, sia per la drammatica contrazione che ha interessato quelli privati durante la crisi (tra il 2008 e il 2016 pari a -34,9%, circa 12 punti in più del resto del Paese), sia per l’emergere di una nuova flessione di quelli pubblici. Una ripresa mutilata, insomma, indice di una debolezza strutturale del tessuto economico delle regioni meridionali di portata davvero straordinaria. Non solo rispetto a un dato di “mera” sopravvivenza del Mezzogiorno e di quello che ciò può comportare per il resto dell’economia del Paese (in termini di fragilità della domanda interna), ma anche rispetto al rapporto, ancor più fondamentale, tra crescita dell’occupazione e insufficiente aumento del Pil, emerso con forza a livello nazionale.
Lungi dall’essere superato, il dualismo che ha segnato la “questione meridionale” fin dal suo nascere si presenta ora sotto nuove e più preoccupanti forme, che gettano un potente faro sui ritardi che stanno minando lo sviluppo complessivo dell’Italia. Il Mezzogiorno è oggi un’area “invecchiata”, con tutte le “caratteristiche demografiche negative di un’area sviluppata e opulenta, senza peraltro esserlo mai stata”[10]. E la situazione appare ancora più patologica se si guarda alla ripresa, all’intensità e, soprattutto, alla qualità dei nuovi flussi migratori. Se da un lato si riduce la componente relativa alla popolazione senza alcun titolo di studio o con licenza elementare, dall’altro aumenta quella relativa ai possessori di un titolo di laurea e quella di coloro che avendo conseguito un titolo di scuola media superiore si iscrivono direttamente ad una Università del Centro-Nord, andando progressivamente a depauperare il “capitale umano” più prezioso, senza il quale perfino il più nobile sforzo di investimento è destinato a cadere nel vuoto[11]. Il rischio che si accompagna a questa nuova fase migratoria – osserva Adriano Giannola[12], Presidente di Svimez – non potrà essere che quello di “risolvere per eutanasia la Questione [meridionale] con non secondari contraccolpi per il Sistema” e sarà sempre più elevato se si ci ostinerà a non voler leggere l’emergenza Sud come un dramma che è di tutta l’Italia.
I fatti, purtroppo, parlano da soli.
Sono anni ormai che l’Italia si colloca fanalino di coda nella classifica europea relativa alla percentuale di popolazione laureata (attualmente il 20% nella fascia di età compresa tra i 25 e i 34 anni contro il 30% della media Ocse), mentre cresce il numero dei connazionali che trasferendosi oltre confine sono in possesso del titolo di laurea (+50% nell’arco decennale compreso tra il 2006 e il 2016). Quest’ultima dinamica appare ancora più allarmante se si considera il fenomeno dei cosiddetti “cervelli in fuga”, un flusso crescente di ricercatori che prendono la via dell’estero, nonostante numerose siano le prove che ne attestano l’elevata qualità della formazione (dalla produttività scientifica misurata sulla base delle pubblicazioni, all’assegnazione dei prestigiosi finanziamenti dello European Research Council, solo per citare le più note). È quindi evidente che anche di quei pochi (e spesso ottimi) laureati di cui dispone, il Paese non sa che farsene. Un’”eccedenza” che sembra tutt’altro che ridursi, considerate le ultime tendenze relative all’aumento di occupazione, che mettono in luce – come visto - un incremento dei lavori a termine e poco qualificati. E, considerato, non ultimo, che l’impiego di laureati in settori ad elevata qualificazione scientifica e tecnologica (su cui risulta sostanzialmente calibrata la domanda di un titolo di studio universitario nei diversi paesi) rappresenta ancora in Italia una quota relativamente esigua dell’occupazione totale (poco meno del 15%) a fronte di un valor medio europeo prossimo al 25% e perfino superiore al 30% in molti economie del Centro e Nord Europa[13].
Diventa allora più chiaro che il particolare dualismo che contraddistingue l’attuale posizione del Mezzogiorno, non è che il tratto più marcato di quella fuga all’indietro che l’Italia ha intrapreso da tempo, con una offerta produttiva che continua ad essere debolmente presente nei settori high-tech per i quali, data la crescente pervasività del progresso tecnologico, più rapida è stata l’espansione della domanda globale. Ciò che in sostanza si sta delineando è una sorta di “doppio dualismo”, che vede innanzitutto l’Italia tra i maggiori interpreti di quella che nel 1991 con una felice locuzione Paul Krugman[14] definì “mezzogiornificazione della periferia europea”, e il Mezzogiorno scontare in maniera più accentuata il divario di sviluppo accumulato rispetto al Centro-Nord. In tale contesto il numero dei laureati meridionali si rivela sempre più “ridondante”, tanto da risultare uno “spreco” e giustificare (di fatto) un processo di progressivo smantellamento degli atenei del Mezzogiorno, quale è quello a cui si sta assistendo[15], attraverso un meccanismo che – nell’ ambito di una generale riduzione del finanziamento pubblico dell’Università - tende a redistribuire risorse verso le sedi accademiche del Centro-Nord (basti pensare che tra il 2009 e il 2016 la riduzione dei fondi ordinari erogati dal Ministero Università e Ricerca è stata del 19% per gli atenei del Sud, contro un taglio del 12,3% di quelli destinati al Centro-Nord)[16]. Un circolo vizioso che non solo non può che prefigurare una lenta morte del tessuto socio economico meridionale, ma anche accelerare quel declino che già sta segnando la “mezzogiornificazione” dell’intera economia italiana. E dunque un circolo vizioso ben più ampio, via via più difficile da recuperare, tenuto conto oltretutto della formidabile ascesa dei paesi emergenti nel processo di industrializzazione a livello mondiale (Cina in primis), che si sta consolidando sulla spinta di crescenti investimenti pubblici in Ricerca e Sviluppo e di politiche industriali tese a rafforzare l’offerta produttiva nei settori ad alta tecnologia[17]. Con buona pace di tutti quelli che invece credono che la competitività internazionale dell’Italia possa ancora (e a lungo) fare leva sulla riduzione del costo del lavoro, ottenuta con una sempre maggiore precarietà dell’occupazione. Ma che non vedono, o fanno finta di non vedere, che lungo questa china il Paese potrebbe giungere a un punto di non ritorno.
[1] Svimez, 2017. Anticipazioni dei principali andamenti economici e sociali dal “Rapporto Svimez sull’economia del Mezzogiorno”, Roma, 28 luglio 2017.
[2] Palma, D., Prezioso, S., 2010. Progresso tecnico e dinamica del prodotto in una economia “in ritardo”. Economia e politica Industriale, Vol. 1 pp.33-74; D’Ippoliti, C., Roncaglia, A., 2011. L’Italia: una crisi nella crisi. Moneta e Credito, Vol 64 n. 255, pp.189-227; Ferrari, S., 2012. Crisi internazionale e crisi nazionale. Moneta e Credito, Vol 65,n. 257, pp.49-58.
[3] Toniolo, G., Visco, V., 2004. (a cura di) Il declino economico dell’Italia. Cause e rimedi. Bruno Mondadori.
[4] Visco, I., 2017. (intervista a) La ripresa è congiunturale. Le imprese devono innovare. Corriere della Sera, 24 agosto 2017.
[5] Saraceno, F., 2017. Leggere i dati sul lavoro. Un po’ di chiarezza su crescita e mercato del lavoro. Il Mulino, 11 settembre 2017.
[6] Saraceno, op.cit.
[7] Saraceno, op.cit.; cfr anche Eurofound, 2017. Occupational change and wage inequality. European Jobs Monitor 2017. https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2017/occupational-change-and-wage-inequality-european-jobs-monitor-2017 e Birindelli, L. (a cura di) Record dei contratti a tempo determinato, occupati a livello del 2008 ma con molte meno ore lavorate, crescita del part time involontario, calo del lavoro autonomo. Fondazione Di Vittorio, 7 ottobre 2017.
[8] Istat, 2017. Rapporto sulla competitività dei settori produttivi.
[9] Svimez, op.cit.
[10] Svimez, op.cit., pag. 39.
[11] Cfr. Lucarelli, S., Palma, D., Romano, R., 2013. Quando gli investimenti rappresentano un vincolo. Contributo alla discussione sulla crisi italiana nella crisi internazionale. Moneta e Credito, Vol.67, n.262, pp. 169-205;
[12] Giannola, A., 2017. Eutanasia del Mezzogiorno. Infiniti Mondi. n. 1., pp. 7-32.
[13] Palma, D., 2016. Cervelli in fuga e gap tecnologico dell’Italia. Italianieuropei 2-3/2016.
[14] Krugman, P., 1991. Geography and Trade. MIT Press.
[15] Giannola, op.cit..
[16] Cfr. anche Greco, P., 2017. Meno soldi alle università e il Sud muore. Left, 29 luglio 2017.
[17] Mazzucato, M., 2014. Lo Stato innovatore. Laterza, Bari; Palma, D., 2017. La Cina, il capitalismo di Stato e la crisi del Washington consensus. Keynes blog. 12 gennaio, 2017.