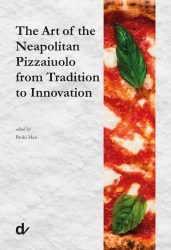SIAMO INFANTI PLANETARI: NON ABBIAMO LE PAROLE PER DIRE IL PRESENTE, MA SIAMO ESSERI CREATIVI, E ALLORA…..
Cominciamo da una lettera di Robert Louis Stevenson ad Arthur Conan Doyle, scritta da Vailima, nel cuore dell’oceano Pacifico, il 23 agosto 1893:
“Mio caro Conan Doyle,
Mi sto riprendendo dopo un’esperienza in qualche modo difficile, sulla quale ritengo mio dovere ragguagliarla. Stasera, subito dopo cena, mi è venuto in mente di rinarrare al mio sorvegliante, il nativo Simele, il suo racconto Il pollice dell’ingegnere. E così ho fatto. È stato necessario, non occorre dirlo, uscire talvolta dal solco da lei tracciato. Per esempio soffermarsi a spiegare cos’è una ferrovia, cosa un maglio a vapore, cosa una carrozza a cavalli, cosa batter moneta, cosa un criminale e cosa la polizia. Sorvolo su altre spiegazioni non meno indispensabili. Ma, in definitiva, sono riuscito nell’intento: se avesse potuto vedere l’espressione tesa e ansiosa e gli occhi accesi e febbricitanti di Simele, avrebbe assaggiato (almeno in quel momento) il sapore della gloria. Di conseguenza, forse penserà che, quando verrà a Samoa, potrà essere presentato come l’Autore del Pollice dell’ingegnere. Non si illuda. I locali non hanno idea che cosa significhi inventare una storia. Il pollice dell’ingegnere l’ho raccontato (Dio mi perdoni) come se fosse un episodio di storia reale e concreta […..]. Oa’u, o lau uo moni, O Tusitala, più comunemente conosciuto come R. L. Stevenson”.

Capirsi non è facile e tra codici linguistici e culturali diversi corrono differenze spesso intraducibili. Il fatto è che le cose e i fenomeni sono radicalmente cambiati e noi abbiamo ancora le parole di prima, che somigliano sempre più a quelle pelli secche di serpenti che si trovano nell’erba in tarda primavera. A vederne una all’improvviso ci si spaventa perché sembra un serpente; in realtà è solo la pelle che, con la mutazione stagionale e uscendo dal letargo, il serpente ha abbandonato. Non solo le parole divengono vuote col tempo, ma diventano incondivisibili, oltre che tra parlanti di culture diverse e di generazioni diverse, tra persone vicine e della stessa storia e cultura. Mai con la velocità con cui tutto questo accade nel nostro tempo attuale.
La paura che ci accompagna in ogni istante induce, tra l’altro, a rinchiuderci nelle nostre parole, nei nostri ordini del discorso, nei nostri rituali, nelle nostre consuetudini, a cui assegniamo un compito eccessivo di rassicurazione che probabilmente non potranno garantirci. E più ne avvertiamo l’inconsistenza, più ci aggrappiamo ad essi.
La condizione non è nuova se si pensa alla sua straordinaria descrizione che ne fa Hugo von Hofmannsthal nel suo capolavoro Lettera di Lord Chandos:
“Il mio caso, in breve, è questo: ho perduto ogni facoltà di pensare o di parlare coerentemente su qualsiasi argomento. In un primo tempo mi divenne gradualmente impossibile trattare temi sia elevati sia comuni e formulare quelle parole, di cui ognuno suole servirsi correntemente senza stare a pensarci. Provavo un inspiegabile disagio solo a pronunciare la parola “spirito”, “anima” o “corpo”. Trovavo impossibile, nel mio intimo, esprimere un giudizio sulle questioni della corte, i fatti del parlamento, o quel che vogliate. E ciò non per qualche sorta di prudenza, e difatti conoscete la mia franchezza che giunge a sconfinare con la leggerezza: ma le parole astratte di cui la lingua, secondo natura, si deve pur valere per recare a giorno qualsiasi giudizio, mi si sfacevano nella bocca come funghi ammuffiti. Mi accadde di voler riprendere Katharina Pompilia, la mia figlioletta di quattro anni, per una bugia infantile di cui si era resa colpevole, e di volerla richiamare alla necessità di essere sempre veritiera; e in quella le idee che mi fluivano alla bocca assunsero di colpo una così labile colorazione e traboccarono le une nelle altre in modo tale che, portata in qualche modo penosamente a termine la frase, come se mi avesse colto un malessere, e davvero pallido in volto e con un forte senso di oppressione alla fronte, lasciai sola la bambina, chiusi la porta alle mie spalle, e appena quando fui a cavallo, preso a buon galoppo sulla prateria solitaria riuscii a riprendermi un poco”.
Il tempo dell’indicibile in cui viviamo non produce solo disagi e difficoltà semantiche e comunicative, ma una inedita “infanzia”: non abbiamo (ancora?) le parole per dire una civiltà planetaria di cui siamo parte e in cui di fatto viviamo. Questa condizione di infanzia planetaria si colloca criticamente tra tempo vissuto e capacità di riconoscere opportunità disponibili. La persistenza in vita di forme linguistiche semanticamente morte, insieme a forme troppo recenti per essere governate e comprese, producono conoscenze e comportamenti alienati, inganni nascosti, come quello della separazione e cesura tra finanza ed economia che ha portato alla crisi strutturale che attanaglia il mondo dal 2007. Se parliamo male, pensiamo male e agiamo peggio. Esiste una stretta connessione tra pensiero e linguaggio: “i limiti del mio linguaggio sono i limiti del mio mondo”, ha scritto Ludwig Wittegenstein.
Sul cedimento del linguaggio, non solo come effetto ma anche come causa della grande crisi, si cimenta con efficacia uno studio del grande antropologo Arjun Appadurai: Scommettere sulle parole. Il cedimento del linguaggio nell’epoca della finanza derivata, Raffaello Cortina Editore, Milano 2016.

Combinando gli indicatori principali dell’andamento di Borsa e le parole caratterizzanti della descrizione e narrazione della crisi, si può cogliere il rapporto fra il lessico e le dinamiche sociali, secondo Appadurai. Secondo l’autore prima del crollo economico, alla base della crisi c’è un cedimento linguistico. La perdita di valore e la perdita di senso del nostro agire economico sono derivate dal dominio dell’economia di carta. Nel mondo della finanza globale sia le merci che il lavoro perdono di senso e di significato. Il danaro, infatti, non si utilizza per comprare beni e servizi ma per comprare altro denaro. Nel gioco di aspettative e promesse non c’è più traccia di un bene reale a cui ancorare le scelte. L’inganno linguistico evidenziato da Appadurai consiste nel fatto che un pezzo di carta, il cui valore è gonfiato ad hoc, diventa carta straccia, quando il valore degli immobili, gonfiato troppo a lungo, crolla all’improvviso e fa venire giù il valore, il significato e le parole che lo hanno prodotto. La “macchina del capitale” non gira più sui cosiddetti “fondamentali”, concreti e corrispondenti a fattori materiali, bensì su parametri ormai insondabili, i grafici finanziari che si limitano a rappresentare i precedenti andamenti di prezzo e su quelli predicono gli andamenti futuri. Quella predizione disancorata da ogni realtà effettiva, secondo Appadurai, non si distingue in nulla “dagli schemi degli astrologi, dei parapsicologia e dai lettori di tarocchi”. Si creano così le credenze diffuse, l’assenza del dubbio e la crisi della critica, lasciando affermare una fede dell’acquistare, del prendere a prestito, del desiderare ancorato all’immaginario e separato dal simbolico, che perdura anche di fronte alle carte di credito bloccate, alle richieste di finanziamento respinte al mittente. Questo mercato finanziario può diventare democratico? Questo si chiede Appadurai, e si risponde che ciò potrà accadere a patto di “una trasformazione radicale dell’architettura del nostro pensiero sociale”. Per non perdere la partita, la cui portata deriva dal nostro modo di narrarla e rappresentarla, Appadurai invoca ancora le parole, che possono “fare”, anziché limitarsi a “significare”. Le parole che ammalano sono le stesse che possono curare. L’errore può essere l’occasione per sviluppare la creatività. Il tempo che porta la crisi è allo stesso tempo gravido di opportunità. Può esistere un rapporto diretto tra creatività ed errore.
Si tratta di partire da un esame di realtà dell’errore e delle sue cause e di considerare le dinamiche generative di ogni errore, la loro dimensione anticipatrice dei futuri possibili. La condizione per fare questo è accogliere l’incompletezza e l’imperfezione di ogni esperienza umana e considerare il ruolo del tempo e del caso come fattori costitutivi di ogni possibilità evolutiva.
“Ho visto anche sotto il sole che non è degli agili la corsa, né dei forti la guerra e neppure dei sapienti il pane e degli accorti la ricchezza e nemmeno degli intelligenti il favore, perché il tempo e il caso raggiungono tutti”. Così nell’Antico Testamento il libro di Qohèlet (9, 11).

Dal posto in cui sono vedo un mandorlo fiorito e alcune api continuano ad entrare dalla finestra socchiusa per la temperatura tiepida esterna. Tutto normale? Certo, perfino gradevole se non fossimo all’inizio di gennaio. Ci crediamo padroni del pianeta, come ha scritto il grande paleoantropologo Ian Tattersall nel suo ultimo libro, ma non è così che stanno le cose. Non solo non vogliamo accorgerci di come siamo messi a causa dei nostri stessi comportamenti, ma ci infastidisce particolarmente l’esame di realtà: non vogliamo sentirne parlare dei nostri errori e riteniamo di possedere un linguaggio che basta a descrivere la nostra condizione. Eppure esiste un rapporto stretto tra creatività ed errore. La possibilità di elaborare efficacemente gli errori è una delle principali condizioni della creatività. E invece la perseveranza nelle cose consuete, per non assumersi l’impegno di affrontare il cambiamento, ci consegna ad una melassa appiccicaticcia che magari ci accorgiamo che non ci piace, ma continuiamo a perpetuarla. L’arte ci può insegnare molte cose e consegnarci l’opportunità di un linguaggio e di azioni inedite che il tempo sempre porta con sé. Ascoltiamo questo racconto di Herbie Hancock:
“Era una di quelle rare serate di perfezione musicale e di totale sintonia con il pubblico; dopo uno straordinario assolo di Miles Davis, in una pausa chiave, inciampai su una corda, stonando clamorosamente. Mi resi subito conto dell’errore. Mi sembrava di aver fratturato una magnifica scultura di cristallo. Ma il vero shok arrivò subito dopo, quando mi accorsi che Davis aveva risposto al mio errore con un’improvvisazione musicale che lo incorporava nel fraseggio rendendolo plausibile. Invece di giudicare la mia stonatura come brutta e sbagliata, Miles la accolse come un input inatteso, trasformandola in qualcosa di bello e virtuoso. Fu una grande lezione d’arte e di vita. Come il buddhismo, anche il jazz è collaborazione, dialogo, tolleranza, altruismo e libertà”. Così Herbie Hancock, alla prima delle sue Norton Lecture il 3 febbraio 2014 alla Harvard University [La Lettura, 9 febbraio 2014].