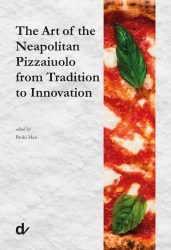Ha ancora senso affaticarsi su testi scritti in un linguaggio scarsamente comprensibile, con strutture sintattiche molto lontane dalla agilità e stringatezza oggi diffuse con i sistemi di comunicazione elettronica, o immedesimarsi in concetti distanti, spesso superati e comunque non sempre in sintonia con le più diffuse sensibilità odierne?
Sono queste le domande “pregiudiziali” di chi si accinga a leggere il più recente libro di Nuccio Ordine. L’autore, dopo averci fatto capire quanto sia utile l’inutile con un suo precedente volume che ha avuto una straordinaria fortuna e oltre 28 traduzioni in lingua straniera (L’utilità dell’inutile. Manifesto, Bompiani Milano 1ª ed. 2013), torna di nuovo all’attacco di tutti coloro i quali ritengano i classici e in generale la cultura umanistica in cui questi sono per lo più rappresentati (ma non bisognerebbe dimenticare che ci sono “classici della scienza” ancora oggi assai utile da rileggere, sia per l’umanista che per lo scienziato) qualcosa di superfluo, di dispensabile; appunto di “inutile”, almeno rispetto ai saperi che si ritengono immediatamente produttivi in quanto capaci di stimolare, crescita, produttività, innovazione, tutti mantra dell’odierna cultura.
Nuccio Ordine nel suo ultimo libro, Classici per la vita. Una piccola biblioteca ideale (La nave di Teseo, Milano 2016) raccoglie i brani tratti da autori classici appartenenti a tutte le culture, pubblicati e commentati su “Sette”, il settimanale del “Corriere della Sera”. Arricchisce tale raccolta un’ampia introduzione in cui, oltre a sottolineare l’importanza dei classici e perché essi «possano rispondere ancora oggi alle nostre domande e rivelarsi un prezioso strumento di conoscenza» (p. 19), l’Autore svolge anche delle amare ma giuste considerazioni su quanto sta avvenendo da un po’ d’anni nella scuola e nell’università.
Le conclusioni che si traggono dalla lettura dell’opera sono nette: i classici non sono un inutile fardello, opere e volumi sdruciti da riporre in qualche polverosa scaffalatura, utili semmai a imbellettare auguste biblioteche di rappresentanza, magari nei negozi di mobili, ma piuttosto uno strumento del pensiero: il “classico” – a nostro avviso – è tale non perché antico o vetusto; non deve il suo valore al fatto di essere solo una testimonianza del passato, ma perché ha rappresentato un momento fondamentale dello sviluppo del pensiero e della cultura umana, un luogo in cui si sono addensati, in modo efficace ed esemplare, i pensieri di un’epoca, l’esperienza di una umanità, ma anche l’originalità di chi ha dissentito, di chi si è dimostrato ‘eretico’ e così annunciato le future eresie e la futura civiltà. I classici sono tali perché stanno sul discrimine: assorbono gli umori del tempo, senza i quali non potrebbero nemmeno essere concepiti, e guardano al di là del loro tempo, come chi sta sul crinale di una montagna e da una parte vede la terra che ha lasciato, dall’altra il paesaggio che potrà percorrere, ancora nebbioso, ma affascinante e suggestivo. Questo viene indicato ai contemporanei, che non sono solo quelli dell’epoca in cui l’autore è vissuto, ma tutti coloro che lo leggono, perché il classico è tale perché in grado di parlare ad ogni uomo di ogni tempo. Ancora oggi andiamo tutti – e vengono i turisti di tutto il mondo – ad ammirare le rappresentazioni classiche delle tragedie di Euripide, Sofocle, Eschilo, messe in scena nel magnifico teatro greco di Siracusa. Cosa ci dicono queste tragedie? Sono forse inutili per chi va ad ascoltarle? A cosa è dovuto il loro fascino? Anche esse sono dei classici e rappresentano passioni, sentimenti, idee che ancora oggi coinvolgono gli uomini, pur esprimendosi in un linguaggio diverso, rivestite da leggende i miti ormai non più creduti, pur appartenendo a una storia giudicata lontana e spesso misconosciuta dagli stessi spettatori.
Solo gli stupidi o gli incolti non si rendono conto di ciò; solo chi non li ha mai letti, ritiene che siano del tutto inutili, così come solo chi non ha mai letto un libro di filosofia pensa che essa sia un vano sproloquio. E qui vengono a proposito le accorate e sferzanti pagine di Nuccio Ordine, che punta il dito sulle condizioni in cui si è ridotto l’insegnamento scolastico e l’esigenza da lui fortemente sentita di «ricondurre la scuola e l’università alla loro funzione essenziale: non quella di sfornare diplomati e laureati, ma quella di formare cittadini liberi, colti, capaci di ragionare criticamente e autonomamente» (p. 17).
Ma proprio questo obiettivo è stato dimenticato negli ultimi anni, con le disastrose riforme che hanno interessato tutto il comparto educativo, governate dall’ossessione dello studio produttivo, utile, capace di rispondere alle esigenze del mercato del lavoro, invitanti a una specializzazione precoce, implementando l’alternanza “scuola-lavoro” (così come prevede la “buona scuola”), creando curricula universitari professionalizzanti, sempre più specialistici e quindi tagliando tutte le discipline inutili, in primo luogo quelle umanistiche. Che posto potrebbero avere i classici in questo desolante panorama? L’attuale sistema educativo sembra che non abbia più interesse alla formazione dell’uomo, ma solo del produttore, dell’operaio, del tecnico, del professionista, dell’esperto. La personalità umana nella sua integralità scompare dietro le categorie economicistiche, dietro la professione che ciascuno deve occupare, l’utilità che bisogna assicurare alla società.
È questo il sistema educativo che anche nel vocabolario ha sposato l’ideologia del più bieco aziendalismo: il preside che diventa “dirigente”, gli studenti che non devono acquisire conoscenze ma “crediti” (o subire “debiti”), non sapere ma “competenze”, i frutti del lavoro scientifico che diventano “prodotti” e così via. Come non ricordare la scuola delle tre “i” proposta da Berlusconi: inglese, internet, impresa? Sembra che per questo aspetto non vi sia stata soluzione di continuità nel tentativo di orientare le scelte educative in base al “mercato”. Ma, avverte Ordine, «Inseguire la chimera del mercato, però, è puramente illusorio. […] La velocità delle mutazioni che investono oggi il complesso meccanismo degli scambi economici è talmente elevata che sarebbe impossibile adeguare, con altrettanta rapidità, i curricula scolastici. La formazione ha bisogno di tempi lunghi. Orientarla esclusivamente sulle presunte offerte del mondo del lavoro potrebbe rivelarsi una sfida perduta in partenza» (p. 22). Non solo, ma si dimentica che le aziende più dinamiche e creative non hanno bisogno di automi specializzati, bensì di gente creativa, dalla mentalità flessibile, capace di adattarsi ai vari ruoli, che rapidamente cambiano e non sono prevedibili con molto anticipo. È loro cura, infatti, assumere le persone più preparate e quindi formarle all’interno dell’azienda. Ma in Italia, aziende ormai in decrescita tecnologica e una classe imprenditoriale incapace e impreparata (tra le più ignoranti dei paesi sviluppati) mirano a scaricare sulla scuola e sull’università le spese che dovrebbero sostenere in proprio, per la preparazione del proprio personale, nella illusione di aver fornito così un prodotto finito pronto all’impiego. E si pensa che la disoccupazione giovanile sia dovuta al fatto che i giovani non siano preparati per il mercato del lavoro, non nel fatto che la produzione industriale sia stagnante e l’economia non cresce. Perché, così come è accaduto in passato e accade negli altri paesi, un’economia dinamica in crescita assume comunque il personale di cui ha bisogno e affronta le spese per la sua preparazione sul campo.
Tuttavia alcuni aspetti della recente cultura di governo sono anche il riflesso dello spirito dell’epoca. La formazione che “ha bisogno di tempi lunghi”, come auspicato da Ordine, è quella che vuole «educare i giovani al rispetto della giustizia, alla solidarietà umana, alla tolleranza, al disprezzo della corruzione, alla democrazia con l’obiettivo di migliorare anche la crescita economica e civile del paese» (p. 48). È quel tipo di educazione e quel genere di conoscenze che – come ammonisce Einstein – è tutto ciò che rimane all’uomo adulto dopo che si è dimenticato tutto quanto ha appreso da studente. Studiare Platone, Aristotele, Spinoza o Kant non serve solo (ma può anche, come dimostra Rovelli!) a ricordarne e riutilizzarne gli argomenti, ma soprattutto a creare un abito di rigore nel ragionamento, nell’abituare la mente a esplorare ipotesi diverse, a non abbandonarsi alla falsa naturalezza delle opinioni e delle culture, assunte come eterne e immutabili. E allo stesso modo, dimostrare i teoremi della geometria euclidea o quelli di analisi, non serve perché domani saranno utilizzati nella professione o perché poi saranno ricordati all’università: qui si ricomincia ex novo e nella vita adulta è oro che cola se ancora si riescono a fare le divisioni con la virgola. No, tutto ciò serve perché dimostrando si impara a dimostrare e si apprende in modo naturale e osmotico a svolgere un argomento deduttivo e a riconoscere quando un ragionamento è corretto o meno. Come sosteneva Galileo, «Il sonar l’organo non s’impara da quelli che sanno far organi, ma da chi gli sa sonare; la poesia s’impara dalla continua lettura de’ poeti; il dipignere s’apprende col continuo disegnare e dipignere; il dimostrare, dalla lettura dei libri pieni di dimostrazioni, che sono i matematici soli, e non i logici». Non quindi arie e discorsi astratti sulla logica, del tutto inutili se non associati alla logica concreta, incarnata dei ragionamenti reali, quelli fatti da matematici e filosofi innanzi tutto. È così che si edifica un “abito mentale” che poi si applicherà sempre nella vita, anche quando si ragiona di politica. Sicché è inutile, come alcuni vanno predicando, fare più matematica nel senso di estendere il programma con nuove nozioni; è importante invece fare buona matematica, far ragionare con la matematica i ragazzi, così come lo si deve fare con la filosofia. E così come lo stesso deve avvenire con i classici.
Ma questi hanno anche una funzione suppletiva. Così come da un computer e dal suo software non si ricava nulla se non vi si immettono dei dati, delle informazioni, così anche la mente logicamente più istruita e formata a nulla di originale giunge se in essa non sono immessi dei dati, che in questo caso sono idee, conoscenze, esperienze: quelle che hanno avuto gli altri uomini e che sono state depositate in monumenti materiali e cartacei, conservati in biblioteche e siti archeologici. Il più bravo dei matematici finirà per ragionare a vuoto – o esprimere banali opinioni tratte dai luoghi comuni dell’ambiente in cui vive – quando va al di là del proprio campo specialistico, se non si nutre di idee. Se insomma non si impregna di tutta quell’esperienza umana che è consegnata nei classici e nella cultura in genere, in quella umanistica in particolare. Ma per far ciò deve avere l’umiltà di riconoscere che anche in letteratura, in filosofia o nell’arte v’è un rigore, un metodo di studio, una tradizione, uno specialismo che bisogna riconoscere, conoscere e rispettare; che non si può ignorare senza poi pagarne pegno; bisogna avere l’umiltà, appunto, di mettersi a studiare, leggere, informarsi e quindi lasciarsi saturare dell’umanità e dei suoi pensieri, passati e presenti. Solo in tal modo si potrà avere quel cittadino auspicato da Ordine, qualunque sia il suo campo di interesse. Ma ciò può avvenire solo nel processo dell’educazione, alla scuola come all’università. Dopo risulta per i più troppo tardi.
Purtroppo ai contenuti disciplinari, allo approfondito studio e alla lettura meditata, che ha i suoi tempi incomprimibili, alla centralità del docente e dell’insegnante, che con la sua cultura e preparazione ha la capacità di rendere vivo il proprio insegnamento, si è sostituita una eccessiva concentrazione sulla didattica, sui metodi di insegnamento, sulle tecniche di trasmissione dei saperi, con tutti i supporti informatici che sono via via entrati di moda e per i quali si spendono, spesso sconsideratamente, fiori di quattrini. In merito potrebbe essere utile riflettere sull’avvertimento di Tadeus Kotarbiński, grande esponente della filosofia analitica e scientifica polacca che, riferendosi ai suoi amici e colleghi della Scuola di Leopoli-Varsavia, metteva nel 1952 sull’avviso di non correre il rischio di affilare continuamente le cesoie e poi non sapere cosa tagliare. Per la “buona scuola” non sono tanto necessarie le lavagne elettroniche e i programmi di digitalizzazione, ma innanzi tutto insegnanti preparati, motivati, appassionati della propria materia, che impieghino il loro tempo anche loro a studiare, preparare le proprie lezioni, leggere ed apprendere; perché «La buona scuola la fanno principalmente i buoni professori» (p. 28).
Quando detto per la scuola è evidentemente anche valido – e direi a maggior ragione – per l’università: il docente è sempre più distratto dai suoi principali obiettivi – ricerca e didattica – dalle sempre più pressante esigenze burocratiche a cui è sottoposto. Ormai gran parte dell’attività di un docente universitario è dedicata a riunioni e compilazioni di moduli, schede, report, sillabi e via dicendo, che nulla cambiano perché restano delle mere esercitazioni cartacee, il cui adempimento è spesso inutile e privo di senso. «L’insensata moltiplicazione di riunioni e di relazioni – destinate a illustrare nel dettaglio programmazioni, obiettivi, progetti, percorsi, laboratori – ha finito per assorbire gran parte delle energie dei docenti, trasformando una legittima esigenza organizzativa in una dannosa superfetazione di controlli amministrativi. Si è dichiarato guerra alla burocrazia, ma la semplificazione tanto auspicata non riguarda, purtroppo, le scuole e le università». (p. 41)
Il richiamo ai classici, dunque, non è altro che un modo per continuare una battaglia per la cultura intesa innanzi tutto come maturazione e progresso interiore, e non mera fungibilità produttivistica. E il successo di tali tematiche presso un largo pubblico testimonia che c’è ancora una società civile che intende e capisce il valore dell’educazione umanistica e rifiuta la stortura aziendalistica; che resiste a quanto sta avvenendo nell’educazione, in Italia ma anche nel mondo, perché ovunque domina ormai quasi un pensiero unico. Ed è triste che tutto ciò avvenga innanzi tutto in Europa, cioè nella patria e nel luogo di origine della cultura occidentale. Ma come può l’Europa difendere la propria identità culturale se non coltivandola nelle scuole, facendone il perno del proprio sistema educativo?