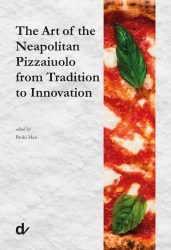Giuseppe O. Longo
La gerarchia di Ackermann
Editoriale Jouvence
Milano 2016
pp. 368, € 20.00
Prima di seguire un itinerario dentro questo romanzo, così intrigante e perturbante, è utile riproporre la classica domanda sulla consistenza della linea di demarcazione tra narrazione e simulazione, indicatrice della compromissione dell’autore con il protagonista del suo romanzo, il matematico Guido Marenzi. Longo ha soggiornato a lungo a Trieste, sua città d’adozione, e a Budapest, i due luoghi deputati della narrazione, e ben conosce la matematica, disciplina nella quale si è laureato, insieme all’Ingegneria elettronica, e che ha praticato nel suo ruolo di professore di Teoria dell’Informazione dal 1975 al 2010 presso il Dipartimento di Ingegneria Elettronica dell’Università di Trieste.
Al problema della demarcazione tra narrazione e simulazione risponde lo stesso Longo, che ha tenuto corsi di “Tecniche narrative e di scrittura” al Master in comunicazione della scienza della SISSA di Trieste e ha scritto il saggio Scienza e letteratura: una figura bistabile? pubblicato in Pietro Greco, a cura di, ArmonicaMente. Arte e scienza a confronto, Mimesis, Milano-Udine 2013, pp. 213-232. «La linea di demarcazione tra narrazione e simulazione – scrive qui Longo – è molto incerta: molte delle storie che ci narriamo sono “inventate”, cioè costituiscono una sorta di simulazione esplicita, anche se adottano il tempo passato; ma anche i racconti che definiamo “oggettivi”, che cioè dovrebbero riprodurre vicende accadute, sono sempre in parte rimaneggiati dal filtro della memoria-oblio e dalla parzialità del punto di vista, e contengono interpolazioni ed estrapolazioni, cioè componenti simulate inserite in un tessuto in linea di principio più “reale”» (pp. 214-215).
Il «filtro della memoria-oblio» e la «parzialità del punto di vista» convergono verso l’ambiguità simulante della narrazione di Longo, condizione necessaria perché in una narrazione sia compresa la “possibilità della verità”. E conducono all’interrogazione di senso sul mondo, che – prosegue Longo – «ha senso e insieme non ne ha: questa doppia e contraddittoria verità, che la scienza non potrebbe sopportare, e nemmeno afferrare, è invece nutrita e fortificata dalla natura enigmatica e allusiva della letteratura e in genere dell’arte» (p. 216).
La gerarchia di Ackermann è un esempio alto di ambiguità simulante, condotta fino al punto di “costringere” l’attivazione – tramite quel processo mimetico del quale rende conto oggi la teoria dei neuroni specchio – di tutti e cinque i sensi: l’udito per la diffusa presenza della musica; il tatto per la consistenza, talvolta ossessiva, dei corpi e del sesso; l’odorato e il gusto per l’attenzione al cibo e agli odori degli ambienti; e naturalmente la vista, con il suo ricco portato di percezioni, allucinazioni, fantasie visive.
Ma è anche un romanzo che “sente” fortemente il tema dell’invecchiamento e della morte, nello scorrere della lunga giornata di Marenzi, il 12 luglio 1989, dopo l’arrivo, da Budapest, di un grosso plico giallo, e nel confronto serrato con un passato che prende forma giusto venti anni prima, il 12 luglio 1969.
L’invecchiamento è segnato dalla dilatazione pervasiva del caos che corrode l’ordine improbabile della vita e del lavoro di Marenzi, professore universitario di matematica, esperto della “gerarchia di Ackermann”. Una corrosione che appare già nella prima pagina con gli accessi di tosse, anch’essi risalenti a quel tempo di vent’anni prima, quando aveva scoperto per caso che l’ineffabile Farkas tradiva sua moglie Eva (cfr. p. 30). La tosse, simbolicamente, scompare alla fine del romanzo, e della giornata: «è una notte afosa, però non ho avuto la tosse, ventiquattr’ore fa tossivo come un cane» (p. 350). Anche il salire e lo scendere affannoso delle scale che portavano «all’ultimo piano dell’enorme edificio della Szász Károly utca» può essere inteso come una metafora del tempo che passa; e soprattutto lo «scendere quelle scale in preda alla vertigine» (p. 11).
Un’altra presenza conturbante che compare dalla prima pagina in questo paesaggio notturno è quella di Heinz-Otto Kühlmorgen, una sorta di motore nascosto di tutte le vicende che danno corpo alla trama del libro, e che verrà riconosciuto dal protagonista come il responsabile di tutto («è stato lui [Kühlmorgen] a catalizzare il processo, a far maturare gli eventi, a istigare me e Farkas», p. 109). La dislocazione dei personaggi del libro, tutti ricchi di prospettiva, segue un gradiente che va dalla massima vicinanza, quella della ex-moglie Giuliana, la cui familiarità è riconoscibile per l’assenza del cognome, a quella di Farkas, che compare alla pagina 10 e rimane così distante ed estraneo da non essere mai chiamato per nome, anzi spesso viene apostrofato con un «Caro Farkas» e con il pronome con la maiuscola. La figura femminile dominante, Eva, sarà anch’essa senza cognome, e segnata dal cognome del marito, Farkas, fino al punto che il protagonista finisce per domandarsi: «come si chiamava Eva da ragazza?» ( p. 298).
Nel «filtro della memoria-oblio» si iscrive, nel primo capitolo, la trama di un’altra storia oscura, in parte onirica e legata a ricordi originari, che non sarà mai decifrata e che evoca donne tedesche e la figura di Adolf Hitler.
Il rapporto tra caos e ordine è intrecciato di contenuti e di simboli, e si sostanzia nella presenza forte della musica – Farkas è uno storico della musica e sta realizzando un’opera monumentale, una Storia della Musica europea da Guido d’Arezzo ai Giorni nostri, che la moglie Eva a un certo punto tenta di bruciare e che non ci è dato sapere se verrà mai conclusa – e della matematica. Marenzi è un matematico rinomato, che sa mettere ordine nel «turbinio delle cose» («Poi un giorno il professore di matematica dimostrò un teorema. Si fece la luce. Esisteva dunque il modo di mettere ordine nel caos, di esorcizzare il turbinio delle cose», p. 281). Ma il simbolo più netto di tale rapporto è quello della scacchiera, che costituisce un punto fermo nella vita di Marenzi e dell’amico e allievo, il matematico Tramer. Il plico giallo arrivato da Budapest scompagina l’ordine fittizio della vita di Marenzi, che, per far posto al pacco, deve spostare i pezzi della scacchiera, sempre pronta per una partita (cfr. p. 22). Gli scacchi, come dirà Tramer, sono «una questione di ordine. È un gioco ordinato, pulito. Fin da piccolo avevo orrore del disordine» (p. 280).
L’ossessione, nella scienza e nella vita, per il disordine viene variamente espressa nel romanzo. Ricorda il protagonista: «tutto ciò che scosta, per difetto o per eccesso, da una norma, non ben definita, ma certo intuibile, di comportamento, dev’esser guardato con sospetto. Bisogna vigilare, bisogna sempre e assolutamente vigilare» (p. 50). Marenzi è ben consapevole che «l’incontro con Sua moglie [Eva Farkas] e con Kühlmorgen introdusse nella mia vita un elemento di instabilità» (p. 51): da quel momento infatti si incrina il rapporto con la moglie Giuliana.
Al «filtro della memoria-oblio» si unisce la «parzialità del punto di vista», evidenziata con efficaci scelte di scrittura. Per esempio con la scarsità dei segni d’interpunzione, che compaiono in modo dettagliato soltanto nel capitolo 3, forse perché qui si introduce un punto di vista diverso dal monologo (interiore) prevalente nel romanzo, e che echeggia chiaramente l’Ulisse di James Joyce. Numerose, in tutto il romanzo, le variazioni di registro stilistico. Particolarmente efficace il capitolo 6, costruito come un interrogatorio realizzato con una sorta di macchina della verità, che serve a riepilogare l’intera vicenda a mo’ di questionario. In questo contesto si leggono frasi del tipo: «ma si tenga a disposizione, può darsi che debba interrogarLa di nuovo. Dipende da ciò che accadrà nei capitoli seguenti. Passi dall’infermeria, si faccia togliere gli elettrodi» (p. 212). E non casualmente alla domanda, retorica, «che cosa c’era dietro i suoi pensieri?» emerge la vera paura che opprime il narratore: «C’era la sua morte. La consapevolezza, lucida, ossessiva, implacabile che un giorno sarebbe anche per lui giunta la morte» (p. 189). La fine di tutto, che si identifica con «la fine del mio rapporto con Giuliana e, in un certo senso, la fine della mia vita» (p. 221), iniziata proprio in quel luglio 1969 a Budapest.
Rimane così dominante il tema dell’invecchiamento, da intendersi come l’incremento di disordine in un sistema di vita personale e sociale apparentemente ordinato. Un invecchiamento che Marenzi vede stampato nell’espressione dell’amico Silvano Bradaschia: «sei vecchio, caro Bradaschia, questa è la verità. Per anni uno si sente uguale a sé stesso. Poi d’un tratto una svogliatezza, un’apatia. Uno dice oggi mi sento pigro, domani andrà meglio, invece no, è cominciato il declino» (p. 106). Ed è anche ciò che capita a Guido con l’arrivo del plico. Un invecchiamento che è soprattutto incremento dell’entropia e riduzione progressiva del rendimento energetico.
In tal senso, una chiave di lettura del romanzo è rintracciabile alle pagine 119-122. La metafora espressa nel romanzo conduce a “vedere” una varietà di persone e di prospettive diverse legate al personaggio principale, che si orienta verso un basso rendimento energetico, sullo sfondo di una Trieste vista come città malata, «luogo contrario alla salute» e favorevole alla malattia e alla morte, come dirà la signora Missio nell’ultimo dialogo del romanzo, il dialogo-monologo dell’incomunicabilità (cfr. p. 322), ma anche «cerniera sensibile tra la vecchia e la nuova geometria» (p. 283). L’informatico sa, ancor più del matematico, che c’è sempre una soglia di “rumore” umano nell’informazione e che, se si riduce il rumore, si produce un’avveniristica macchina perfetta, integrata in una società di automi, che elimina del tutto l’umanità. Il libro si candida a mettere in scena il rumore, il girare a vuoto, del protagonista e della varietà dei suoi interlocutori, ovvero a rappresentare il funzionamento dell’umanità, con il suo caos integrato, e con esso l’invecchiamento di uomini e cose, che vive nel ricordo e nella ricorsività della memoria.
Non a caso Emilio Pausler, il professore di filosofia, vorrebbe azzerare i ricordi: «i ricordi ci rendono schiavi, c’impediscono di vivere»; «nella memoria vedo una certa incompatibilità nei confronti della vita» (p. 136).
Il tentativo di sfuggire al caos probabilistico per semplificare matematica e vita (la prima è nel romanzo metafora della seconda; cfr. p. 133) è destinato al fallimento: «molti vorrebbero tagliare il cordone ombelicale che lega la matematica ai reni, alla milza o alla fede e alla lussuria per ottenere una scienza fredda, angelica, non perturbata dal disordine, dalle passioni. Ma così facendo la matematica morirebbe con tutti i suoi teoremi e il corpo sopravvivrebbe benissimo, con la sua gola e la sua superbia, la sua giustizia e la sua prudenza» (p. 282). Il caso, espressione del caos probabilistico, ritorna con il plico giallo proveniente da Budapest, e la memoria-oblio, tramite la narrazione, cerca di assestare o di riassestare la vita.
Sia detto per incidenza, il romanzo vive della forza greve della parola; il suo autore vive nella parola, si crogiola nell’affabulazione, evidenziando il paradosso dell’informatico che aveva cercato di cancellare la semantica della comunicazione e si ritrova a nuotare in un oceano di parole e di senso. Come diceva nel suo corso universitario Ferdinand de Saussure e come ridisse nei suoi seminari Jacques Lacan – langue e parole si compenetrano dialetticamente. Tutto il romanzo è uno sforzo di squarciare l’ordine della langue tramite la varietà polimorfa della parole.
Un disordine che è anche sociale e sessuale, rappresentato dalle adultere che «introducevano in una società ordinata e giusta come un orologio un elemento di disordine» (p. 227). Quando, parlando con Pausler, Marenzi descrive il fallimento di una società che vorrebbe essere esatta e matematica, perché l’approssimazione ha un posto privilegiato e ineliminabile anche nella matematica, aggiunge però che non ci salva neppure una società poetica, perché, all’estremo opposto della polisemia, gli uomini-poeti non sarebbero in grado di capirsi (cfr. p. 141). Non resta che la descrizione del lento declino personale e sociale di un mondo inserito e travolto dalla memoria e dal tempo storico.
Quando appare, alla pagina 140 il titolo del romanzo si inizia a capire che cosa sia la “gerarchia di Ackermann”, espressione suggestiva, ma senza alcun riferimento alla matematica – come ha confessato pubblicamente l’autore. È una bella metafora e allude, nel romanzo, a una costruzione indefinita che assomiglia alla torre di Babele. La gerarchia di Ackermann viene immaginata come una torre, «una torre altissima, lucida e nera, cinta di bagliori cerulei» (p. 294): «Ackermann gettava le fondamenta della sua gerarchia, presaga torre di Babele brandeggiante contro il cielo infoscato di Gottinga» (p. 306). E Marenzi confessa alla “sorda” signora Missio: «ognuno dei miei teoremi sulla gerarchia di Ackermann è come una lucida scheggia piantata per l’eternità nel cervello del mondo e la gerarchia è nel suo complesso una scheggia immensa come una montagna, svettante come una torre» (p. 324). Per inciso notiamo che esiste invece una funzione di Ackermann, che si deve al matematico tedesco Wilhelm Friederich Ackermann: essa è definita ricorsivamente e associa un numero naturale A(m,n) a ogni coppia di numeri naturali (m,n) e cresce più rapidamente di qualsiasi altra funzione. Per esempio A (4, 2) è un numero intero di 19.729 cifre (la costante di Avogadro ha solo 24 cifre!). La funzione di Ackermann è una bella rappresentazione della complessità delle dinamiche vitali e umane che sono messe in scena nel romanzo, in quanto viene espressa da un calcolo computazionale che diventa sempre più complesso. Forse la gerarchia di Ackermann allude alla successione di funzioni sempre più complesse generate al crescere del parametro m.
Questa complessità sopraffà Marenzi portandolo alla decisione finale, che è un rinuncia a decidere; alla pagina 254 per la prima volta si legge: «non so se avrò mai il coraggio di aprire [il plico]». Il plico, la complessità inestricabile delle sue vicende diventa per Marenzi un malattia incurabile: si è procurato «una di quelle malattie che si chiamano incurabili» ed «è già troppo tardi» (p. 259). E neppure l’ultima comparsa nelle epifanie dei personaggi, il pittore Janowitz, che vuole svincolarsi dal tempo e dallo spazio per «scoprire la trama del mondo» (p. 263), riuscirà a sfuggire alla malattia mortale: «Una volta sperava di non morire. Cercava di svincolarsi dal tempo e dallo spazio, poi ha capito che non ce l’avrebbe mai fatta» (p. 279). Il pittore Janowitz è un mago della prospettiva, della variazione polisemica delle prospettive, che infrange l’univocità pesante, e matematica, della verità. È sua la rappresentazione, anche pittorica, della gerarchia di Ackermann: «non esiste una formula semplice che ci riveli la verità. La verità è diffusa, è sparsa dappertutto, in minuscoli frammenti, come dopo un’esplosione» (p. 266). Janowitz, con un verso di straordinaria liricità, ci dirà che «ognuno è una fisarmonica sotto la luna» (p. 268) e che «la nostra è onnipotenza, ma è onnipotenza delle ombre» (p. 279).
Non resta che il riconoscimento desolante dell’inesauribile efficacia del male, ovvero del disordine: «il male era una costante universale, era una conseguenza funesta del principio antropico al pari della carica elementare e della velocità della luce» (p. 273). E non resta che richiamare il parallelismo tra matematica e vita, con la metafora di Trieste sullo sfondo. La matematica contemporanea ci ha dato i teoremi di incompletezza di Gödel mettendo a nudo «la roccia friabile e dolente dei fondamenti della matematica», e insieme «la debolezza della nostra anima» (p. 281). La grande epica del nostro tempo non richiede più un Omero ma un Cantor e un Gödel: «Se Omero vivesse oggi non scriverebbe l’Odissea, ma un trattato di matematica sublime. In fondo Gödel è l’Omero dei nostri giorni, Cantor è il nostro Esiodo» (p. 281), perché tramite Gödel «le profondità rarefatte e delicate dei fondamenti» della matematica hanno fatto emergere «lo Schmerzpunkt in cui la matematica tocca il resto del mondo e ne trae tutta la sua forza» (p. 282). Ecco che allora è proprio grazie alla matematica, la scienza per eccellenza di una presunta purezza e precisione, di un ordine inconcusso, che si scopre che l’aleatorietà «è nell’essenza del mondo» e che «prevedere l’evoluzione di una sistema complesso è impresa difficile, a volte impossibile» (p. 283). Dinanzi all’abisso del male, e del caos, svelato insieme dalla matematica e dallo scorrere della vita, Marenzi perde ogni certezza, si ritrova a giocare la parte del cattivo: «si era sempre immaginato buono, ma forse, in quella partita, il cattivo era lui» (p. 289). E riconosce infine di aver sbagliato tutto: «forse ho sbagliato tutto. Ho sbagliato la mia vita. Ho fatto delle cose che hanno distrutto qualcuno. Ho distrutto Eva, ho distrutto Giuliana» (p. 310).
Con questa scoperta definitiva, che distrugge per sempre l’illusione di «rendere esatta la vita» (p. 346), si chiude il romanzo nel suo esito imprevisto, ma forse iscritto nell’incremento del male necessario, del «male nell’ordine» (per riprendere la nota espressione che compare nello Zibaldone di Giacomo Leopardi alla pagina 4511 del 17 maggio 1829). Longo mette in gioco le scritture più alte del Novecento, da Kafka a Musil, da Joyce a Proust, e per dovere di cittadinanza a Svevo, per far trionfare la gerarchia di Ackermann dinanzi all’ineluttabilità del trionfo del caos e della morte: «il continuo parlare degli uomini è il paravento, anzi è la manifestazione di questa follia, è insieme la manifestazione della follia e il paravento dietro cui essa si nasconde» (p. 330).