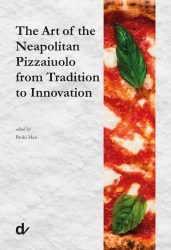Quando la scienza va a teatro incontra l’uomo e le sue narrazioni. È questa la tesi di fondo che attraversa tutte le 400 pagine e oltre del volume, La scienza va a teatro per l’appunto, in cui Giuseppe O. Longo ha raccolto, per la EUT (Edizioni Università di Trieste), tutte le sue opere rappresentate in palcoscenico.
Per chi non lo conoscesse, Longo rappresenta l’ideale dell’uomo calviniano che, reinterpretando continuamente il ménage a trois tra scienza, filosofia e letteratura, cerca di dipanare la complessità del mondo e uscire dal labirinto, peraltro sempre più fitto, nel quale viviamo. È, infatti, scienziato (professore emerito di teoria dell’Informazione dell’Università di Trieste), filosofo di fatto in ogni suo atto comunicativo e letterato eclettico, che attraversa tutti i generi, dal romanzo agli articoli giornalistici, dai saggi divulgativi fino, appunto, al teatro con rara ricchezza e padronanza della lingua. Ma la singolarità di Giuseppe O. Longo è che queste sue tre dimensioni si esprimono e si intrecciano in ogni momento. In questo il professore forlivese che vive a Gorizia è, in qualche modo, la reincarnazione dell’intellettuale rinascimentale.
Un intellettuale che esprime idee forti. Una è, per l’appunto, è che quando la scienza va a teatro non possa – non debba – svolgere un ruolo pedagogico, ovvero trasmettere le sue nozioni e i suoi concetti attraverso le parole e le situazioni dei personaggi che calpestano il palcoscenico, ma possa – debba –, come Diogene, cercare l’uomo. Sentirlo narrare.
È una posizione, appunto, molto forte. Persino radicale. Che pone dei limiti a una forma di comunicazione, il teatro, che forse non li sopporta. In fondo in tempi recenti non sono stati pochi – da Luca Ronconi a Carl Djerassi – coloro che hanno cercato di rappresentare sul palcoscenico la scienza e non (solo) gli scienziati.
E, tuttavia, non c’è dubbio che la scienza quando va a teatro possa cercare l’uomo. E i modi in cui narra se stesso e il mondo. E se stesso nel mondo. E il sé che cambia in un mondo che cambia. Insomma, tutta la complessità di quel labirinto che la scienza e la tecnologia rendono sempre più intricato.
Tutto questo lo potete trovare in ciascuno dei 13 testi e delle diverse chiose raccolte da Giuseppe O. Longo in La scienza va a teatro. Distillate nelle parole di Lucrezio e di Pascal, di Babbage e di Einstein, degli scienziati tedeschi ospiti forzati a Farm Hall e del cervello che trasmigra da un corpo all’altro scoprendo la sua nudità. Ma per un assaggio preliminare della tanta carne con cui Longo ricopre il suo pensiero in questi testi teatrali vi rimandiamo a tre passaggi.
Il primo riguarda la creatività. Un tema tra i più cari a Longo. Il suo pensiero lo esprime a pagina 43 per bocca del Blaise Pascal. Il matematico francese ribadisce che la creatività degli scienziati (e non solo) emerge attraverso due canali: l’esprit de geometrie e l’esprit de finesse. Il primo è un canale analitico, logico, geometrico appunto. Il secondo è il canale dell’intuizione. Ma per Pascal (e per Longo), c’è una differenza qualitativa e, quindi, profonda tra i due: con il lavoro e la fatica l’esprit de geometrie si può apprendere. Mentre per l’esprit de finesse c’è poco da fare: chi ce l’ha ce l’ha, chi no non la può acquisire.
Ci sarebbe forse da aggiungere che quasi sempre l’esprit de finesse esiste allo stato latente. È una sorta di energia potenziale. Solo nel contesto giusto e con un certo allenamento può emergere. Se Michelangelo fosse nato nel deserto e non nella Firenze rinascimentale e non avesse studiato anche le scienze, difficilmente il suo esprit de finesse dallo stato potenziale sarebbe divenuto attuale.
Saltiamo ora a pagina 137, dove inizia il testo di Un trapianto molto particolare. Qui c’è poco da fare. Bisogna leggerlo tutto. Per tre motivi. Il primo è per godere di dell’ironia raffinata che accompagna la narrazione di un cervello (e, dunque, di una mente) che passa da un corpo all’altro conservando la propria identità. O forse no. Perché i cambiamenti del contesto fisico contribuiscono, magari in piccola parte, a cambiare anche la mente. Il secondo motivo è la lingua: la ricchezza del vocabolario è, lo abbiamo detto, rara; l’uso dei termini i giochi con le parole, magistrale. Il terzo motivo riguarda il contenuto. La ricerca dell’uomo e la bellezza della narrazione porta Giuseppe O. Longo lì dove dice che il teatro non deve arrivare: insegnarci com’è fatta la mente.
Infine spostiamoci a pagina 213 e ascoltiamo Werner Heisenberg e forse scopriremo tutto il dramma umano – scopriremo l’uomo – in cui è stata precipitata suo malgrado la “generazione quantistica”. Nella Germania di Hitler e, di converso, negli Stati Uniti di Roosevelt. C’è chi, in Germania, “la bomba” (leggi la nuova arma di distruzione di massa basata sulla fissione dell’atomo) la vuole costruire esplicitamente, a maggior gloria del Führer e della patria. C’è chi, in maniera più o meno consapevole ma mai esplicita (vero, Werner Heisenberg?), invece cerca di boicottare l’impresa. E c’è, infine, chi rinuncia in maniera chiara e inequivocabile a partecipare alla realizzazione dell’arma di distruzione di massa. Tra i reclusi nelle comodità di Farm Hall ci sono svariate sfumature tra questi tre idealtipi. Così come ce ne sono a Los Alamos, negli Stati Uniti. Tutti, o quasi, impegnati nel e angosciati dal dovere di governare lo spirito che hanno fatto uscire dalla bottiglia.
Ecco, a Farm Hall, Giuseppe O. Longo incontra l’uomo. E i suoi fantasmi.