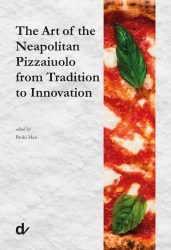«Pecché nun fa juorno? Che vo’ di’ sta nuttata?» Così gridava una donna che si copriva la testa con uno scialle «con una voce che non doveva essere la sua normale, piena di collera, come se il suo orizzonte non fosse il medesimo, chiaro e delicatamente colorato, che noi vedevamo, e anzi non vedesse più le cose umane, ma si trascinasse in un sotterraneo».
Dopo la “mazzata” del III e IV Granili («Una delle cose da vedere a Napoli, dopo le visite regolamentari agli Scavi, alla Zolfatara, e, ove ne rimanga tempo, al Cratere, è il III e IV Granili, nella zona costiera che lega il porto ai primi sobborghi vesuviani»); dopo quella mazzata l’altra della mia prima lettura de Il mare non bagna Napoli fu proprio questo «Pecché nun fa juorno? Che vo’ di’ sta nuttata?».
E queste due mazzate per anni hanno costituito il ricordo più vivo di questo romanzo di Anna Maria Ortese che non si dovrebbe mai dimenticare e che molto opportunamente è ritornato all’attenzione il 9 marzo 2018 in occasione del ventesimo anno dalla morte della Ortese.
Occasione per porre una lapide a ricordo a via Ferdinando Palasciano dove la scrittrice aveva vissuto negli anni del dopoguerra e prima di relegarsi a Rapallo, città che pure due anni fa le aveva dedicato una lapide.


Ma, direi ancora di più propizia è stata l’occasione colta dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli (Nino Daniele) per ricordarla in un incontro a Palazzo San Giacomo, sede del Comune di Napoli, protagonista Valeria Parrella.
È stata una scrittrice prolifica, ma quello che più di altri viene associato al suo nome è Il mare non bagna Napoli pubblicato da Einaudi nel 1953 e “rilanciato” da Adelphi quarant’anni dopo, nel 1994. Due edizioni che andrebbero tenute entrambe in biblioteca (ma la prima non la si trova e chi ce l’ha se la tiene) per almeno un motivo: quella del 1953 ha nel risvolto di copertina la “presentazione” di Elio Vittorini; la seconda ha un’addolorata premessa della Ortese.
Vittorini spiega brevemente come l’Einaudi arrivò a questa scrittrice nata a Roma, vissuta lungamente a Napoli, che ebbe una notorietà di fanciulla prodigio, poco prima dell’ultima guerra per un libro che Bontempelli chiamò, lanciandolo, Angelici dolori. E spiega i cinque “scritti” del libro. Di un libro così intenso da indurlo a scrivere che con esso «Napoli ha finito per raggiungere la stessa intensità d’immagine che Firenze ha raggiunta da tempo con Palazzeschi e Pratolini». Quella Napoli della Ortese che è «di tutta la sua vita ch’essa si vede intorno, presenza e memoria insieme, e riflessione, pietà, trasporto, sdegno».
Malgrado ciò, proprio a Napoli il libro suscitò opposizioni e malumori. In modo particolare da parte di quegli scrittori napoletani (parliamo di Rea, La Capria, Compagnone) che si erano sentiti “umiliati e offesi” per il capitolo Il silenzio della ragione che chiude il libro. Tanto che la Ortese lasciò Napoli che, a prescindere dal luogo di nascita, era la sua “patria” per non tornarvi mai più se non un giorno per qualche ora. E tanto da indurla quasi ad un’autocritica nella premessa apposta alla edizione di Adelphi del 1994, nella quale esprime tutta la sua malinconia: «Resta il fatto piuttosto malinconico (o solo inconsueto?) che tanto la Napoli offesa (era, poi, veramente offesa, o solo un po’ indifferente?), quanto la persona accusata di averle inventata una atroce nevrosi, non si siano, in seguito, più incontrate: proprio come se nulla fosse avvenuto. E non era stato così, per me».
E nulla aveva inventato. E per capirlo che era tutto vero va letto questo libro. E per chi, non avendola vissuta, volesse conoscerla a fondo questa Napoli dell’immediato dopoguerra, andrebbe letto insieme con Napoli ’44 di Norman Lewis (Adelphi): «Napoli era come una puttana malmenata da un bruto: denti spezzati, occhi neri, naso rotto, puzza di sporcizia e di vomito. […] I bambini offrivano sorelle e madri in vendita. Di notte, durante l’oscuramento, dalle case sbucavano a frotte i topi e se ne stavano semplicemente lì, a guardarli con occhi rossi, senza muoversi. Si camminava evitandoli. Gli uomini e le donne di Napoli erano un popolo diseredato, affamato, disperato, disposto a fare assolutamente tutto per sopravvivere. L’anima della gente era stata stuprata. Era veramente un città senza dio». Né trascurerei di consigliare Anthony Capella, L’ufficiale di matrimoni (Neri Pozza), più romanzo, ma non per questo meno documentato su quei lunghi, tragici momenti.
Perciò è stata veramente propizia l’occasione di ricordare il ventesimo anniversario della morte di Anna Maria Ortese e di farlo invitando Valeria Parrella a ricordarla.
Propizia l’occasione perché più gente la conosce e la legge più si è indotti a fare “giustizia”, per così dire di certe posizioni sempre più prive di senso.
Propizio l’invito alla Parrella perché Valeria è una scrittrice dalla produzione “tosta” che, come si dice, prende e scuote. Vale per tutti i suoi libri sino all’ultimo divertimento (per sé e per il lettore) di “aggiornamento” della Enciclopedia della donna. E, anche per tutto questo, è una scrittrice che può raccogliere il testimone idealmente e inconsapevolmente lanciatole dalla Ortese e da Fabrizia Ramondino. Un testimone di scrittrice napoletana, anche se contrariamente alle altre due, ha scritto meno di Napoli (e farebbe bene a farlo).